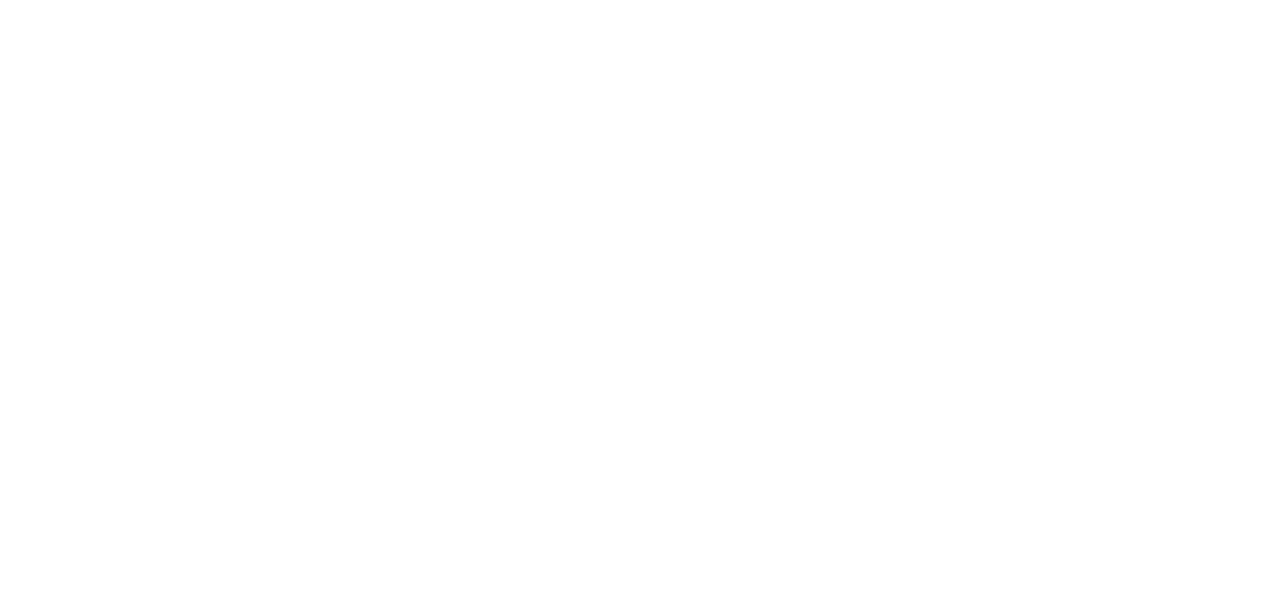Si è già scritto e detto parecchio, sul tema, oscillando fra chi ha ecceduto in sentenze sommarie (tutto illecito, tutti evasori, bloccare coercitivamente i movimenti di capitale) e chi si è arroccato dietro ad alibi autoassolutori (alta pressione tributaria, inefficienza dello Stato, tutela della proprietà personale). Nessuna delle due reazioni pare razionalmente corretta; entrambe, infatti, denotano una mancanza di consapevolezza dei termini “tecnici” su cui valutare la questione (ed anche dei termini “oggettivi” di ciò che siano davvero quei “papers”).
Il fronte giustizialista è il primo ad aver mosso le sue argomentazioni (invero facilitato – e tanto – dagli eventi). Un (ennesimo) elenco di nominativi “colti con le mani nel sacco”, “nascosti” in un’isola esotica, “sicuramente” evasori (“sennò cosa ci farebbero lì”?), vieppiù tutti “famosi” (o quasi), tutti “ricchi” (più o meno), di numerosi Stati (che l’evasione è “un comportamento diffuso e trasversale”), anche qualche soggetto “politico” (in carica e non, di paesi occidentali e non) non poteva passare sotto silenzio. Salvo dimenticare che parte di quelle informazioni potrebbero riferirsi a capitali leciti e dichiarati (vige, nel mondo occidentale, il principio generale di “libertà di circolazione” dei capitali, rispettando le regole fiscali “interne” a ciascun Paese di volta in volta coinvolto) o a capitali già “regolarizzati” (ad esempio in Italia, ma anche in altri Stati, con meccanismi simili agli “scudi” o alla “voluntary disclosure”) o dimenticando di distinguere fra capitali “privati” e “pubblici” (stante la presenza in quegli elenchi di “persone politicamente esposte” anche di Paesi in via di sviluppo) ovvero derivanti da attività economiche lecite o da attività criminose vere e proprie. Inoltre, sottacendo il fatto che – giuridicamente parlando – è un nuovo caso di leaks, ovvero perdite di dati (con conseguente loro diffusione) coperte da segreto – professionale o bancario – dovute ad atti (o acquisite con metodi) fraudolenti.
Il fronte giustificazionista, invece, ha risposto argomentando (anche ricorrendo a citazioni, peraltro errandone a volte l’interpretazione, di illustri personalità passate) la necessità di “tutelare la proprietà privata” dall’invasività dell’erario, giustificando (spesso) il ricorso a questi comportamenti elusivi con i dati della (elevatissima, in Italia) pressione tributaria complessiva e elevando “a sistema” singole scelte individuali (l’evasione), attribuendo arbitrariamente loro un significato filosofico quasi quanto azioni “collettive” tipo scioperi o manifestazioni di protesta di massa. Salvo dimenticare che la tutela della proprietà privata è un principio (almeno da noi) costituzionale, che l’incidenza del prelievo fiscale è frutto di scelte politiche (di spesa e di entrate) che non si cambiano certo ricorrendo all’evasione dei singoli, che spesso le citazioni a sostegno erano per lo più paradossi per stigmatizzare comportamenti economici dei governi (di allora) eccessivamente lassisti, che – infine – le scelte di quel tipo di comportamenti sono (e restano) “singole” (per convenienze personali) e non certo “collettive” (legate a movimenti di protesta sistemici – che invero nel lontano passato vi sono anche stati ma, appunto, “collettivi”) e che (tralasciando qui la disquisizione “tecnica” su imposte, tasse, servizi pubblici, spesa e debito pubblico) non “cambiano” lo stato delle cose, anzi gravano ancor più sui soggetti che adottano comportamenti più “corretti” (riequilibrio con future maggiori entrate, per spese già impegnate, poiché le correzioni sistemiche sono ad effetto più lungo nel tempo; fruizione di servizi, infrastrutture e benefit senza contribuire alla loro copertura).
A parere di chi scrive necessita, dunque, un invito alla razionalità, per comprendere davvero il fenomeno in questione, senza cadere in uno dei due eccessi prima descritti. Partendo dal duplice presupposto che sì, da un lato, vi sono (oggettive, anche gravi) sperequazioni e/o inefficienze “di sistema” nel nostro ordinamento fiscale e nelle dinamiche della spesa pubblica; ma la via per “risolverle” non è certo quella di “singolarmente” sottrarsi (in tutto o in parte) alla contribuzione vigente, e, dall’altro, la “libera circolazione dei capitali” (regolari rispetto alle normative “interne”), che genera i flussi di investimenti nei paesi ritenuti più attrattivi (o stabili) economicamente, non può essere “limitata” a causa di singoli comportamenti “illeciti” (più o meno diffusi”), restando un tema attinente alle scelte “politiche” il creare o meno le condizioni per favorire afflussi o deflussi di capitale.
Il “contrasto” all’economia irregolare o agli abusi fiscali va fatto, ma non a scapito del funzionamento corretto dell’economia “sana” e (probabilmente) si ottiene più con misure “preventive” (efficienza delle infrastrutture, stabilità economica, incidenza fiscale sostenibile) che con misure solo “punitive” (ricorrendo a sistemi coercitivi di limitazione alle libertà economiche o ripristinando sanzioni draconiane, attinenti alla sfera penale o meno).
Ma cosa sono (davvero) i Panama Papers? Tutto nasce parecchi mesi addietro, con una email anonima che raggiunge Bastien Obermayer, giornalista del SudDeutsche Zeitung. Lo sviluppo di quei contatti porta ad ottenere 11,5 milioni di documenti (se fossero stampati tutti, sarebbero più di 35 mila libri), contenenti i registri digitalizzati (probabilmente agendo fraudolentemente in violazione del segreto professionale ivi esistente) di 40 anni di attività dello studio panamense Mossack y Fonseca. L’analisi (giornalistica) dei dati, data la loro mole, ha coinvolto un progetto internazionale coordinato dall’ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) e formato da 370 giornalisti di oltre 90 testate (L’Espresso per l’Italia).
Insomma, una mole enorme di dati, una serie impressionante di reazioni mediatiche, qualche errore già emerso; certo uno strumento di pressione anche strumentalizzabile. Circa 800 connazionali coinvolti, non tutti ancora disvelati. Dati, però, da prendere con molta attenzione. Intanto per il periodo temporale, poiché alcune cose potrebbero non essere più sussistenti ed altre prescritte o regolarizzate nel tempo. Poi, perché, come già detto, potrebbero esservi proprietà, capitali ed investimenti esteri “regolari” per il fisco, poiché la detenzione di conti o società cd. “off shore” non è (di per sé) “prova” di comportamenti irregolari. Infine, occorre levarsi dalla testa l’idea che si tratti di denari e capitali depositati “in quell’isoletta esotica”, poiché per la maggior parte sono intestazioni di società costituite in altre giurisdizioni (off shore e non), spesso per detenere investimenti immobiliari e finanziari in paesi ad alta fiscalità o, come in molti casi sta emergendo, per “aggirare” l’euroritenuta sui proventi finanziari introdotta dal commissario europeo Monti, che non si applica(va) alle persone giuridiche.
Va poi ricordato che le regole internazionali di contrasto all’evasione ed elusione internazionale ci sono e sono in progressiva (recente) evoluzione (sempre più stringente). Nel 1990 l’Italia toglieva le limitazioni al libero trasferimento dei capitali. Ed era nel 1998 (meno di vent’anni: nulla sotto il profilo storico!) che introduceva la tassazione sui capital gain finanziari, mentre l’Ocse emanava l’ormai datato Harmful Tax Competition report. Nei primi anni 2000 (a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle) si introdussero multilateralmente provvedimenti in deroga al segreto bancario (anche in quegli stati “collaborativi” che lo “tutelavano” nella loro costituzione) che portarono al sequestro e alla confisca dei capitali finanziari di una lista di persone ed enti giuridici “fiancheggiatori” del terrorismo internazionale. Sempre in quegli anni, la pressione internazionale crebbe, generando in vari Paesi provvedimenti sul genere degli “scudi” del ministro Tremonti, gli accordi cd.
Rubik della Svizzera ed un maggior ricorso alla cooperazione giudiziaria internazionale in tema di antiriciclaggio (e, connessa, seppur inizialmente in maniera più latente, in tema di compliance fiscale). Poi, in rapida successione in questi ultimi anni, l’US Tax Program svizzero, la FATCA (accordi bilaterali con gli USA), i CRS (Common Reporting Standard) in ambito Ocse sullo scambio di informazioni finanziarie e fiscali (siglata anche da Svizzera, Hong Kong, Singapore, MonteCarlo e altri ormai ex paradisi fiscali), che – pur già in vigore oggi – entrerà a regime nel suo automatismo nel 2018. E, in Italia, si è poi aggiunta la norma sulla “voluntary disclosure” (seppur nata male e gestita non benissimo: 129.525 istanze per circa 58/60 miliardi di euro regolarizzati, con introiti fiscali stimati in minimo 3,8 miliardi iniziali) e, da non sottovalutare nella sua portata, l’introduzione del nuovo reato di “autoriciclaggio”.
Piaccia o meno, il ruolo dei professionisti fiscali e finanziari, peraltro colpiti da un inasprimento delle eventuali sanzioni, risulta essere così messo “al centro” del sistema di prevenzione degli illeciti finanziari (e fiscali), in Italia come a livello internazionale. Ruolo, per i commercialisti, da non temere, se ancorati a principi deontologici di “etica della responsabilità individuale”, salvo sostenere con forza la necessità di porre maggior attenzione, negli eventuali controlli, a questioni sostanziali, piuttosto che meramente formali. Ruolo che, se svolto con consapevolezza, può mettere la nostra Professione al centro anche di due piccole proposte concrete, che ben possono vederci sia come “promotori” che come “interpreti”.
La prima delle due proposte attiene all’esigenza di riaprire (migliorandola), come norma da portare stabilmente a regime, la voluntary disclosure (facendo attenzione a non penalizzare chi vi ha già aderito, magari ancorando il periodo iniziale oggetto di eventuale regolarizzazione al 2010, indipendentemente dall’anno di effettiva adesione), così da farla diventare una sorta di “ravvedimento operoso premiale” per le questioni internazionali.
La seconda attiene all’esigenza di riequilibrare il sistema fiscale garantendo un maggior rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente; persa la chance di elevarlo a rango costituzionale, si potrebbe proporre la costituzione di un’apposita Authority fiscale “terza”, il cui coordinamento sarebbe affidato per metà a commissari di nomina ministeriale e per metà di nomina professionale, cui affidare (sottraendolo – con tanto di porzione dei dipendenti coinvolti – alla sfera dei poteri di MEF/AdE/Equitalia, che ora contemporaneamente legifera, interpreta, accerta, escute, transa, rilascia interpelli preventivi e coordina i garanti del contribuente) i poteri di interpretazione delle norme, interpello preventivo e coordinamento dei garanti, dando con ciò maggior attuazione “neutrale” ai principi contenuti nello Statuto stesso.
Favorire, come richiesto sempre di più, una maggior adesione spontanea dei contribuenti alle normative vigenti, sia a livello internazionale che domestico, “passa” per un maggior “presidio” proprio su “quei” principi ed il ricorrere ad un’autorità “terza”, coinvolgendo la nostra Professione, dovrebbe poter garantire un clima di maggior “fiducia” istituzionale.
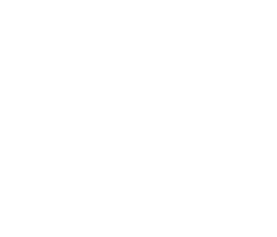
fisco
Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentaleRegalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura”
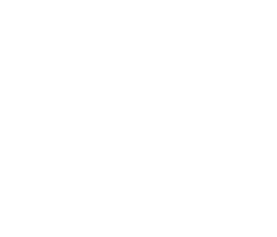
diritto
Enti del Terzo Settore, convegno nazionale commercialisti il 14 febbraioParteciperà la Ministra del Lavoro Calderone. Per il Consiglio nazionale saranno presenti il Presidente de Nuccio, il Vicepresidente de Tavonatti e il Consigliere delegato Moro. Focus su evoluzione normativa e prassi professionale
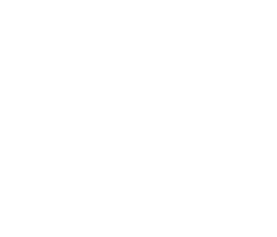
fisco
Telefisco, il 26 gennaio il presidente de Nuccio parteciperà alla 32^ edizioneIl Consiglio nazionale dei commercialisti metterà gratuitamente a disposizione degli iscritti l'evento. Basterà iscriversi entro le ore 18 del 25 gennaio