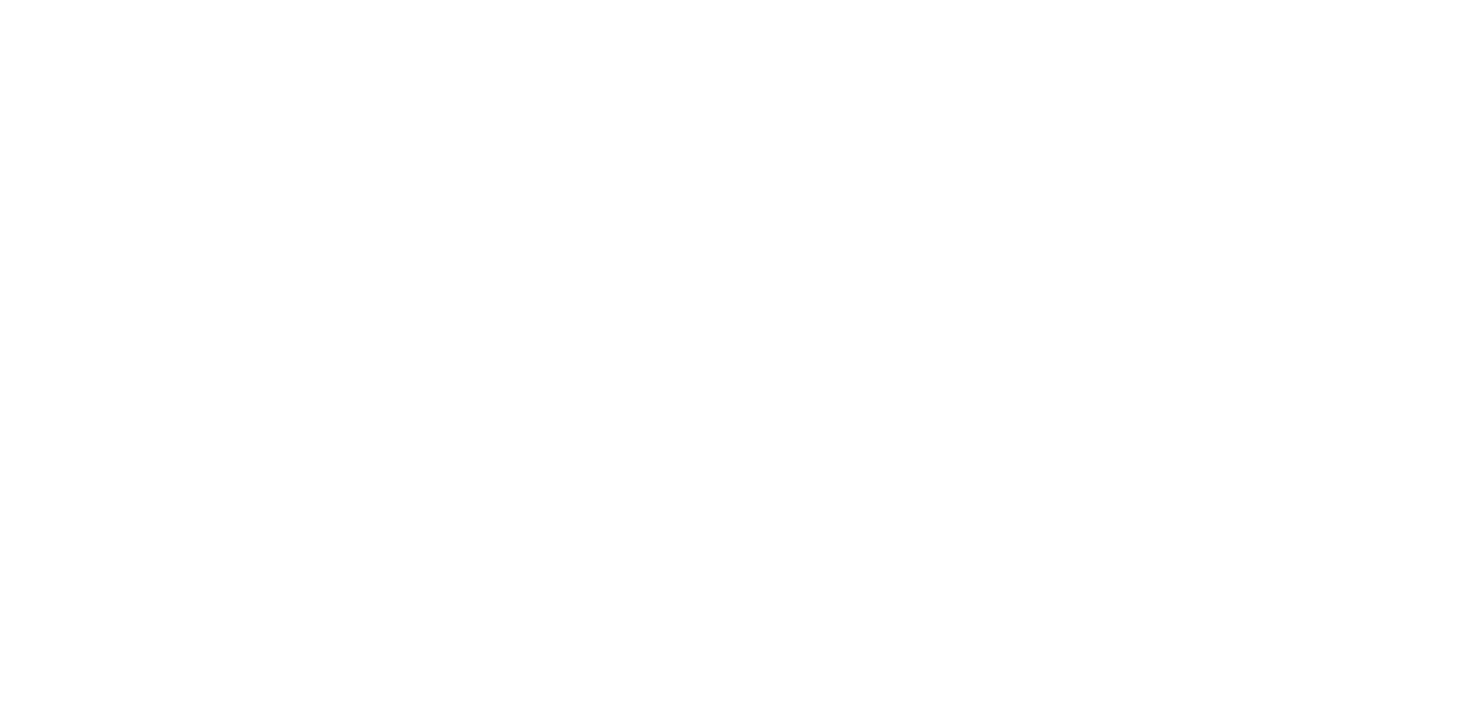La crescita del prodotto interno lordo italiano nel 2015 si è assestata (dopo le correzioni per il calendario) al +0,6% sancito dagli ultimi dati Istat, con una successione trimestre dopo trimestre non certo incoraggiante (+0,4 nel primo; +0,3 e +0,2 nei successivi e +0,1 nel quarto). Le stime per il primo trimestre 2016, pur in presenza di un buon dato (oltre le aspettative) sulla produzione industriale ad inizio anno, sono comprese in un range fra -0,1 e +0,3% e le ultime previsioni per l’anno in corso parlano di una crescita intorno al +1% o poco più, su base annuale, dovendosi così rivedere in leggero ribasso le stime originariamente contenute nel Documento di Economia e Finanza del Governo.
Dall’inizio della crisi, secondo sempre le stime desumibili dai dati ufficiali, l’Italia ha perso circa il 20% della produzione industriale (con un picco del -37% nel settore delle costruzioni ed un minimo del -7,2% nel settore dei servizi). Il tasso degli investimenti, nel periodo 2008/2013, ha registrato un -24,7% (contro un -15,7% della media UE), mentre gli investimenti in ricerca&sviluppo si attestano ormai stabilmente intorno ai 10 miliardi di euro annui complessivi (del 61% in meno rispetto alla Francia e del 77% in meno rispetto alla Germania).
Eppure, siamo tuttora il secondo paese manifatturiero della UE.
Solo, forse, oltre a tutti gli altri problemi che abbiamo – di equilibrio delle finanze pubbliche, di efficienza delle infrastrutture (anche immateriali ed amministrative), dei tempi biblici di pagamento dei debiti commerciali (anche fra imprese: 95 giorni contro i 46 medi nella UE) e della giustizia (soprattutto in sede civile) – ne abbiamo anche uno costituito dalla struttura del nostro sistema-imprese.
Siamo “entrati” nella crisi (cioè “prima” di quegli effetti citati più sopra) con questi dati:
I) il peso dei settori tradizionali a basso valore aggiunto e bassa intensità tecnologica costituiva circa il 30/31% del valore aggiunto totale prodotto, contro il 29% della Francia ed il 18% della Germania;
II) il peso del valore aggiunto, sul totale prodotto, dei settori a tecnologia medio e medio-alta era di circa il 38% (la quota del segmento ad alta tecnologia si fermava al 6,5/7%), contro il 41% della Francia ed il 56% della Germania;
III) la dimensione media delle imprese per unità di addetti in Italia resta di poco inferiore a 4, in Francia appena superiore a 6 ed in Germania è circa 12; circa il 94/95% del totale delle imprese è definibile come “micro” (organico inferiore a 10 persone e fatturato non superiore a 2 milioni di euro), il 4,5% “piccola” (rispettivamente, 50 e 10 milioni), lo 0,5% “media” (rispettivamente, 250 e 50 milioni), meno dello 0,10% “grande”.
Un sistema imprenditoriale, il nostro, forse eccessivamente frazionato (numero molto più alto della media UE nel segmento delle “micro”), in cui la differenza sui dati di produttività del lavoro (seppur in parte “sporcata” dai dati del “sommerso”), intesa come valore aggiunto sul numero di addetti, è enormemente legata al fattore dimensionale (circa 27mila euro per addetto, per le “micro”; circa 61mila per addetto, per le “grandi”), che fatica a reggere il passo con un’economia sempre più globalizzata ed interdipendente, mostrando chiari segni di perdita di competitività generalizzata (e ciò nonostante i dati tuttora crescenti del segmento esportazioni, anche – va detto – negli anni dell’euro).
Un sistema di imprese piccole e “micro”, che rappresentano circa il 65% della forza lavoro complessiva, ma per loro natura con scarsa capacità predittiva, con alto ricorso all’indebitamento, intrinsecamente più rischioso a livello di rating attribuibile, con scarsa propensione ad investimenti di R&S, che si regge – ad onor del vero – soprattutto sulla serietà dei singoli soggetti-imprenditori (molto più frequente dei casi, che pur vi sono, di patologia fraudolenta). Un sistema che ha avuto maggiori difficoltà a reagire alla crisi e, ora, contribuisce in misura meno reattiva al rilancio dell’economia e degli investimenti.
Ecco perché – a sommesso giudizio di chi scrive – occorrerebbe promuovere un contesto più favorevole (economico, finanziario e fiscale) alle aggregazioni fra imprese: rendendole più contendibili si disincentiverebbe il sommerso, favorendo le acquisizioni si migliorerebbe una selezione positiva dei soggetti imprenditori e si indirizzerebbero investimenti e finanziamenti ad un maggior grado di specializzazione, favorendo la crescita per linee esterne si otterrebbe la riduzione del gap con la media UE del fattore dimensionale e, stando ai dati di analisi prima riportati, si genererebbe un effetto positivo di contributo a PIL e produttività media.
Non serve che siano “tutte” grandi; servirebbe che la “dimensione media” crescesse. Pensare ad ipotesi come semplificazione (ulteriore) nei processi di fusione e di conferimento dei rami aziendali, “super-ACE” per i patrimoni netti conseguenti le aggregazioni e/o “maxi-ammortamento” degli avviamenti, agevolazioni finanziarie (e fiscali: detassazione dei maggiori redditi conseguenti) alle acquisizioni aziendali, o altro ancora (che, come Categoria, ben potremmo essere promotori) eventualmente individuabile (meglio di quanto in queste poche righe si possa fare), non costituirebbe un onere eccessivo per l’erario e potrebbe invece produrre effetti positivi alla nostra economia.
E, nondimeno, nascerebbe così anche una maggior richiesta di specializzazione nei percorsi di crescita, negli aspetti giuridico-fiscali delle operazioni straordinarie, nelle tematiche di finanza d’impresa e di strutturazione di business plan industriali: specializzazioni (e crescita) anche per i commercialisti.
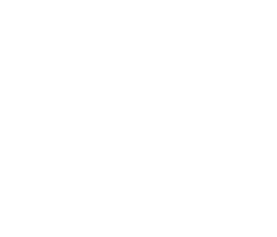
fisco
Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentaleRegalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura”
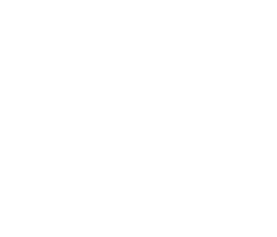
diritto
Enti del Terzo Settore, convegno nazionale commercialisti il 14 febbraioParteciperà la Ministra del Lavoro Calderone. Per il Consiglio nazionale saranno presenti il Presidente de Nuccio, il Vicepresidente de Tavonatti e il Consigliere delegato Moro. Focus su evoluzione normativa e prassi professionale
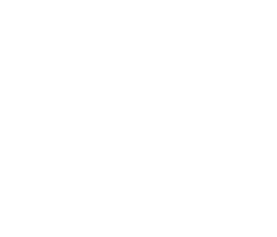
fisco
Telefisco, il 26 gennaio il presidente de Nuccio parteciperà alla 32^ edizioneIl Consiglio nazionale dei commercialisti metterà gratuitamente a disposizione degli iscritti l'evento. Basterà iscriversi entro le ore 18 del 25 gennaio