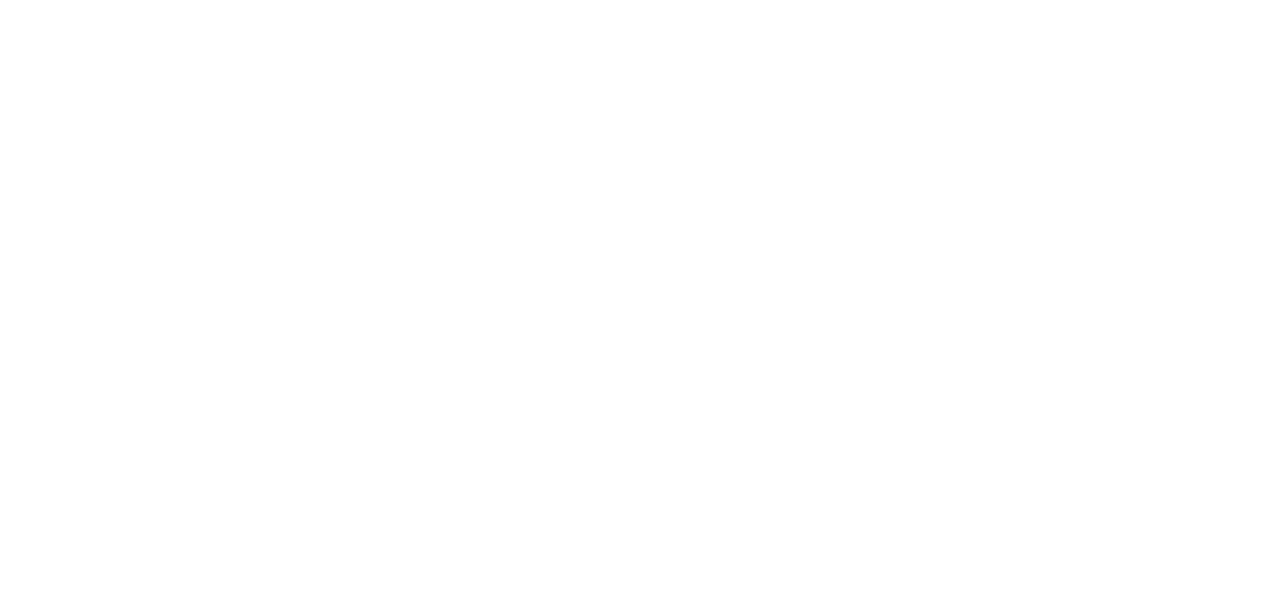Nel fosco panorama dell’economia italiana si sono intravisti nelle ultime settimane alcuni raggi di sole. La produzione industriale nel mese di marzo è tornata a crescere (+1,5% rispetto all’anno precedente); ad aprile il numero dei nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato ha superato di 48 mila unità le cessazioni (+52% su aprile 2014) e anche l’andamento dei prezzi è tornato a mostrare il segno più (+0,2% a maggio), dopo aver fatto vivere per qualche mese lo spettro della deflazione.
Ma mentre questi timidi segnali di ripresa si fanno avanti, all’orizzonte si profilano nuvole nere per imprese e famiglie: la clausola di salvaguardia inserita dal governo nella manovra di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) prevede dal prossimo 1° gennaio un graduale aumento dell’IVA, che potrebbe portare l’aliquota ordinaria del 22% e quella ridotta del 10% a crescere rispettivamente di 3,5 punti e 3 punti percentuali. La prima salirebbe al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 e al 25,5% nel 2018. La seconda al 12% nel 2016 e al 13% dal 2017. A ciò si accompagnerebbe, sempre dal 2018, un nuovo rincaro delle accise sui carburanti, al fine di assicurare maggiori entrate per almeno altri 700 milioni di euro annui.
Come indica il comma 719 della legge, gli aumenti scatteranno qualora non venissero adottati nel frattempo «provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica». Dietro la locuzione “stessi effetti positivi sui saldi” si annidano in realtà 53 miliardi di euro complessivi per il triennio 2016-2018, che il governo dovrà trovare sotto altre forme per “disinnescare” la clausola di salvaguardia.
Laddove ciò non avvenisse – come dimostra uno studio della Fondazione nazionale dei commercialisti predisposto in esclusiva per Press – gli ulteriori aggravi dell’imposta sul valore aggiunto impedirebbero all’Italia di agganciare la ripresa: gli aumenti dell’IVA già scattati tra il 2012 e il 2014 hanno già causato effetti negativi sulla domanda interna, che ha invece ripreso a crescere in altri paesi come Regno Unito o Spagna. A testimoniarlo c’è l’andamento del gettito IVA nei primi quattro mesi dell’anno: come riportato dal Bollettino sulle entrate tributarie internazionali diffuso dal Dipartimento delle finanze nei giorni scorsi, il gettito IVA nel periodo gennaio-aprile 2015 ha fatto registrare una crescita più o meno sostenuta in Irlanda (+10,3%), Spagna (+9,3%), Portogallo (+9,2%), Regno Unito (+2,9%) e Germania (+2,6%), mentre la variazione positiva dell’Italia si è fermata allo 0,6%.
Il documento della Fnc esamina l’evoluzione della pressione fiscale italiana tra il 1980 e il 2014. L’andamento dell’onere tributario complessivo sopportato dai contribuenti italiani è andato di pari passo con quello della spesa pubblica, del deficit, del debito e degli interessi sul debito (voce, quest’ultima, che oggi come oggi rappresenta la principale ragione del sistematico “rosso” nel bilancio dello Stato, dal momento che il saldo primario è in attivo). Con la crisi economica e finanziaria scoppiata su scala globale nel 2008, la pressione fiscale ufficiale è salita al massimo storico del 43,5% nel 2012, anche per effetto dei numerosi prelievi introdotti nel decreto “salva Italia” nel dicembre 2011. Il tax rate si è poi stabilizzato intorno al 43,4% nel biennio 2013-2014.
«Nel corso del tempo, però, la pressione fiscale ha mutato composizione e struttura», commenta Tommaso Di Nardo, ricercatore della Fondazione che ha curato lo studio: «Dopo il riequilibrio strutturale verificatosi negli anni ’90, il rapporto tra imposizione diretta e indiretta è profondamente mutato a seguito della crisi economica iniziata nel 2007. La crisi, infatti, ha provocato un calo di gettito che – dati i vincoli al deficit dell’Italia – ha costretto il governo nel 2011 ad aumentare le aliquote Iva. In questo modo la pressione tributaria indiretta, che era scesa al di sotto di quella diretta all’inizio della crisi, è ritornata a salire».
La lunga rincorsa delle imposte indirette a quelle dirette si è conclusa nel 1998, quando il gap di gettito tra le due macro-voci è stato colmato. Da lì e per i successivi nove anni le imposte indirette hanno superato in termini di importo quelle dirette, fino a che l’esplodere della crisi non ha causato una repentina frenata dei consumi. A quel punto le manovre finanziarie del 2011 (che hanno ritoccato all’insù le aliquote) e il calo generalizzato dei redditi hanno riportato per un paio d’anni le imposte indirette a prevalere, fino a che l’ulteriore aggravarsi della congiuntura negativa nel 2013 (con il Pil a -2,5%) ha provocato un ulteriore abbassamento del gettito.
«E’ un cane che si morde la coda», ha aggiunto Di Nardo, «poiché più si aumentano le aliquote IVA e più si alimenta la crisi che a sua volta, riducendo i consumi, genera un calo di gettito».
A conferma dell’eccessivo carico fiscale sopportato dai contribuenti (e in particolare le aziende) è intervenuto anche l’ultimo aggiornamento Doing Business, il rapporto annuale elaborato dalla Banca Mondiale. Sul fronte fiscale, l’Italia mostra un total tax rate (ossia un prelievo tributario in percentuale sui profitti delle imprese) pari al 65,4%, superata solo dalla Francia che ha raggiunto il 66,6%. La Spagna è, invece, più indietro con il 58,2%, mentre Germania e Regno Unito si fermano rispettivamente al 48,8% e al 33,7%. Se a ciò si aggiungono l’elevato numero di pagamenti fiscali richiesti in media ai contribuenti ogni anno (15, contro una media internazionale di 8 o 9) e le ore impiegate per adempiere agli obblighi fiscali (269, rispetto alle 218 della Germania o alle 110 del Regno Unito), è facile capire il perché del cattivo ranking dell’Italia sotto il profilo dei tributi (141° posto su 189 paesi considerati, dietro paesi quali Sudan, Nepal, Sierra Leone, Burundi e Siria).
L’analisi macroeconomica sull’andamento del gettito erariale non può però non tenere conto dell’economia sommersa. La pressione fiscale ufficiale, infatti, è calcolata dividendo le entrate complessive (tributi e contributi previdenziali) con il Pil. Il prodotto interno lordo, secondo il principio di esaustività delle stime di contabilità nazionale, incorpora una parte di economia sommersa (vale a dire cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in evasione di imposta).
«Nel 2008 il sommerso già contabilizzato nel Pil secondo l’Istat era al 16,2%», spiega Di Nardo nel documento di ricerca. «Ciò vuol dire che la pressione fiscale reale, ovvero la pressione fiscale calcolata mettendo al numeratore tutte le entrate fiscali e al denominatore il Pil al netto del sommerso era molto più alta di quella normale (o ufficiale o apparente come altrimenti detta). In particolare, nel 2008, secondo i dati Istat, la pressione fiscale reale sarebbe stata pari a 49,3% invece di 41,3%, cioè 8 punti di Pil più alta».
Secondo tale ragionamento, la pressione fiscale reale avrebbe raggiunto il 51,9% nel 2014 (invece che il 44,3% ufficiale), ma è possibile solo avanzare ipotesi dal momento che l’Istat dal 2008 in avanti non ha più diffuso il dato riguardante la stima del sommerso.
Lo scorso anno, però, in virtù di una normativa europea che ha coinvolto tutti i paesi dell’UE, l’Istituto nazionale di statistica ha modificato i criteri per la quantificazione del sommerso, al fine di uniformarsi ai nuovi standard internazionali. In questo modo sono state inserite anche alcune voci dell’economia illegale, tra le quali traffico di droga e prostituzione: con riferimento al 2011, pertanto, l’Istat ha ricalcolato la stima del sommerso già contabilizzata nel Pil pari all’11,5%, cioè 187 miliardi di euro, a cui si aggiunge lo 0,9% di economia illegale. Nel 2012, sempre secondo l’Istat, l’economia sommersa è salita all’11,7% del Pil, mentre l’economia illegale è salita all’1%, pertanto l’economia non osservata è pari complessivamente al 12,8% del Pil.
Ma il documento della FNC riporta anche delle stime effettuate dal prof. Schneider dell’università di Linz, in base alle quali il sommerso in Italia nel 2013 risulterebbe pari addirittura al 21,1% del Pil. «Ciò fa pensare all’esistenza di una quota di Pil che resta nascosta, nonostante gli sforzi dell’Istat di misurare il sommerso secondo gli standard europei e internazionali», aggiunge Di Nardo, «rispetto al 12,8% già contabilizzato, vi sarebbe dunque un altro 8,3% di Pil ancora sommerso». A fronte di tale visione, la pressione fiscale effettivamente sopportata dalla collettività sarebbe decisamente più bassa (40,1% nel 2014, in linea cioè con quella della Germania). Quest’ultimo dato, confrontato con il Total Tax Rate sui profitti delle società calcolato dalla Banca mondiale, pone in evidenza il macroscopico divario esistente in Italia, divario impareggiabile tra i paesi più avanzati, tra il carico fiscale sopportato dalla collettività nel suo insieme e quello realmente a carico delle imprese che producono profitti.
Tale rappresentazione appare coerente con i numeri ufficiali diffusi dal ministero dell’Economia nel rapporto annuale sull’evasione fiscale del 2014. Il documento, basato sui dati dell’Agenzia delle Entrate, parla di un tax gap pari a 91 miliardi di euro annui. Si tratta della differenza tra ciò che lo Stato riscuote e quello che avrebbe dovuto incassare in teoria in caso di perfetto adempimento fiscale. Il concetto di tax gap è più ampio di quello di evasione fiscale, perché ricomprende anche le imposte non dichiarate a seguito di errori nella compilazione delle dichiarazioni e le imposte dichiarate ma non versate a causa della crisi di liquidità dei contribuenti.
Ebbene, tra il 2001 e il 2011 il tax gap IVA in Italia si è attestato nel range compreso tra 35 e 45 miliardi di euro annui. Con riferimento alla stessa imposta, il tasso di “non compliance” (ossia la percentuale di IVA sottratta rispetto a quella potenziale) ha superato di poco il 30% dal 2011 in avanti, anche a causa degli incrementi di aliquota, a fronte di una media europea attestatasi costantemente tra il 18% e il 20%.
Recuperare almeno in parte le imposte evase su questa rilevantissima base imponibile occulta consentirebbe al governo di disporre di un ingente volume di risorse, utile sia a ridurre il prelievo fiscale sia a prevedere incentivi e agevolazioni per le imprese, senza doversi necessariamente avvalere della clausola di salvaguardia sull’IVA dannosa per la domanda interna e quindi per la ripresa dei consumi.
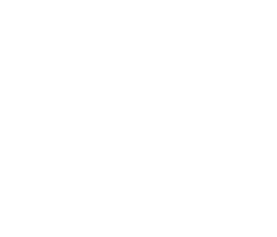
fisco
“No a responsabilità solidale degli intermediari per inizio attività IVA”De Nuccio e Regalbuto: “Norma che determina un ingiustificato aggravio di responsabilità”
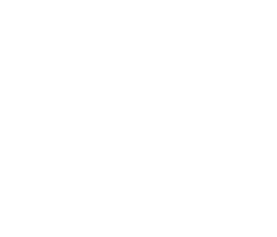
fisco
De Nuccio: “Grande attenzione per i temi d’interesse per la professione”Razionalizzazione del calendario fiscale, semplificazione degli adempimenti e riforme del sistema fiscale e della giustizia tributaria i temi al centro della riunione
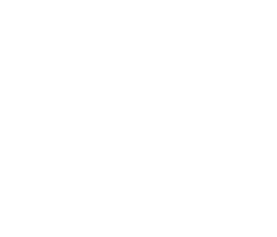
internazionale
WomenTechEU, triplicata la dotazione finanziaria per le start-up femminiliL'iniziativa dell'Unione europea rientra nell'ambito del programma di lavoro Orizzonte Europa 2021-2022