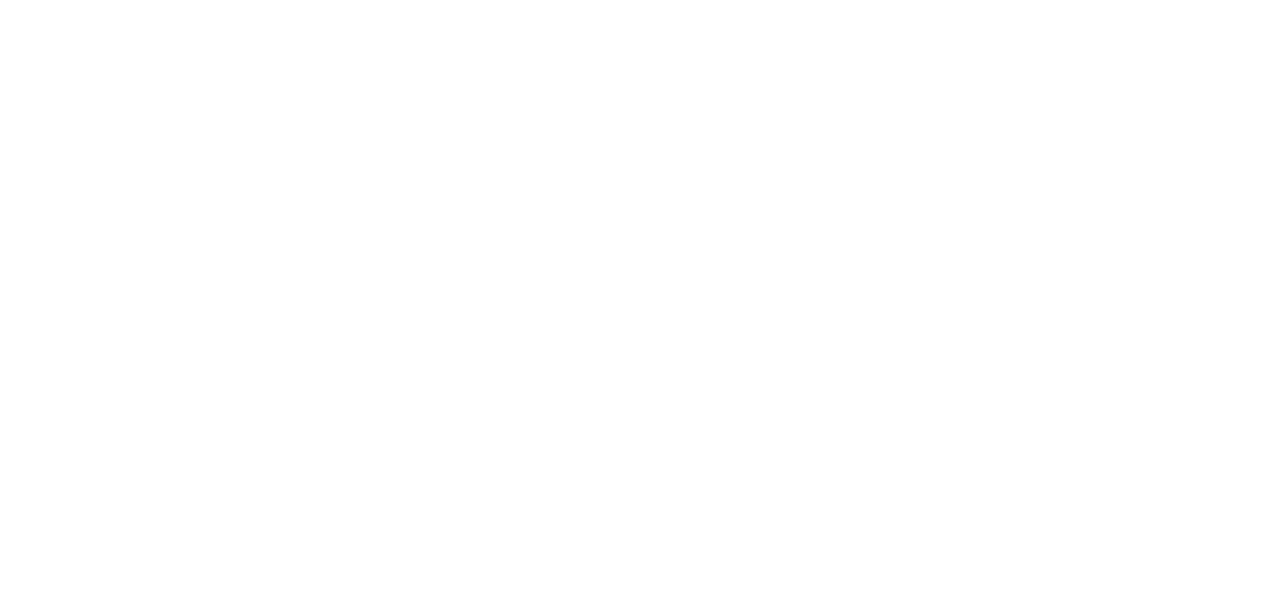Ha destato scalpore, sui giornali, il “lancio” del primo titolo di Stato italiano a 50 anni, per 5 miliardi di euro al tasso fisso del 2,85% ed integralmente sottoscritto in poco tempo. Ma, invero, quale “lezione” trarre da questo avvenimento economico? Vuol dunque dire che non sono previsti (eccessivi) innalzamenti dei tassi di interesse per un periodo così lungo? Quali effetti vi saranno, per i sottoscrittori (e per lo Stato), se invece i tassi saliranno? E, ancora, perché occorre comprendere (sempre) meglio le dinamiche finanziarie per poter gestire (o consigliare) un’impresa od un patrimonio di famiglia?
Capire di economia (e di finanza), in un mondo globalizzato come quello attuale, non è più solo un requisito per chi si occupa specificamente di investimenti finanziari o di bilanci pubblici, ma è diventata una “necessità” (anche) per tutte le pmi (e per le famiglie) che quasi quotidianamente dialogano con il proprio commercialista. Costringendoci tutti, con più consapevolezza, ad affrontare le tematiche (apparentemente) più generali che (invero) condizionano le singole scelte di investimento o di indebitamento che si vanno a prendere.
Spesso, peraltro, ci si domanda se occuparsi di questi problemi cercando di avere una visione d’insieme abbia poi così senso, stante la (invero frequente) fallacia delle previsioni (rectius, dei modelli di previsione utilizzati) degli economisti e dei leader del mondo della finanza. Domanda alla quale risulta facile rispondere con un pizzico di razionalità: le previsioni servono per “scenarizzare” il futuro e comprendere gli effetti di ciò che potrà accadere, valutando per tempo “come” intervenire, piuttosto che per indicare un futuro su cui “scommettere” a prescindere. Facile, come risposta; non molto diffusa (e compresa), invero.
Ma perché oggi si parla di tassi bassi? E sono un bene od un male?
Uno dei vantaggi (pochi, secondo alcuni; molti, secondo altri; sicuramente innegabile, sotto il profilo oggettivo, questo) dati all’Italia dalla moneta unica, consiste appunto nell’aver ottenuto tassi di interesse minori rispetto ai periodi precedenti. I tassi sono infatti effetto “anche”, assieme alla valutazione del “rischio” del debitore e delle dinamiche di volta in volta contingenti dei mercati finanziari, delle aspettative sull’inflazione; queste sono scese dal livello (medio annuo dell’era pre-euro) dell’8% circa (con punte anche a doppia cifra) al livello attuale (prima intorno al 2% tendenziale, ora intorno allo 0,5% medio, dopo aver toccato anche terreno negativo). Anche il “rischio percepito” dai mercati (almeno fino allo scoppio della crisi – e delle speculazioni, in parte – sui debiti sovrani dei paesi “periferici”) è diminuito con l’ingresso nella moneta unica, che ha agito come “protezione” aggiuntiva (anche) per le mosse della BCE di Draghi a difesa dell’euro stesso.
Un paper della BCE sugli effetti del QE (rectius, in Europa, prima CE – credit easing, manovre note come LTRO – poi QE – quantitative easing, seppur “tecnicamente” diverso da quello americano) afferma che (i) negli USA il primo QE ha comportato una riduzione dei tassi pari a 90 punti base, (ii) in UK di circa 50 punti base, (iii) in Eurozona di circa 63 punti base medi ponderati fra i vari paesi. Per l’Italia, dunque, oltre ad un “primo” effetto di riduzione dei tassi progressivo a partire dal momento della decisione politica di ingresso nell’euro, presa a cavallo fra il 1996 e il 1997 (poi continuato con l’attuazione della moneta unica, cosa facilmente riscontrabile in qualunque grafico finanziario del periodo, seppur, ad onor del vero, effetto non tutto attribuibile “matematicamente” solo all’euro), vi è stato anche un “secondo” effetto di riduzione (stimabile, per fare una sintesi forse eccessiva, fra lo 0,6 e l’1%) a seguito delle manovre della BCE.
Il dato medio degli interessi sul debito pubblico, per dire, è oggi ben lontano sia dai tassi a doppia cifra dei primi anni 90 (anni caratterizzati da inflazione elevata) che dai picchi del 2011 (in contesto di inflazione molto più bassa ma di spread elevati, rispetto al resto dei paesi Eurozona, Germania in particolare, dovuti al “rischio Italia”) che hanno sfiorato la soglia psicologica del 7,5/8% (al momento della famosa prima pagina de Il Sole 24 Ore con un “fate presto” a caratteri cubitali), ed il collocamento del btp cinquantennale al 2,85% è lì a dimostrarlo.
Quindi un bene per l’Italia, che i tassi siano bassi (e sotto controllo). Ma è davvero tutto così positivo? Quali altri effetti comportano i tassi bassi? E, soprattutto, cosa succede se restano a lungo così bassi?
Il Prof. Santorsola, in un recente dibattito, ha definito (mi sia consentita una forse imprecisa citazione, ma il senso era il medesimo) i tassi bassi (quand’anche negativi) sostenibili, nel breve periodo, come fossero anestetizzanti per un malato, ma sostanze per tenerlo in coma farmacologico, nel lungo periodo. Difatti, in estrema sintesi, retto l’urto della speculazione contro l’euro (ed i debiti dei paesi “periferici”), i tassi bassi generano alcuni effetti perniciosi e non semplici da gestire, tra i quali spiccano, per pericolosità sistemica e senza contare il tema della deflazione economica: (i) una spinta al “moral hazard” finanziario (le istituzioni finanziarie – banche, fondi di investimento, fondi pensioni – per incrementare i loro rendimenti da offrire alla clientela tenderanno ad alzare il grado di rischio medio del loro portafoglio di investimento) e (ii) un’erosione dei margini economici delle banche (data dalla contrazione della forbice fra tassi attivi e passivi) che, sommata agli effetti delle svalutazioni di bilancio per NPL (rectius, crediti deteriorati; cresciuti per effetto della crisi), determina una maggior vulnerabilità del sistema finanziario per possibili futuri default (determinando nuove procedure di bail in) e, di conseguenza, aumentando l’esposizione del settore ad attacchi speculativi sui mercati (che a loro volta, per il “peso specifico” delle banche sui mercati, determinerebbero ulteriore instabilità finanziaria).
I tassi bassi, quindi, sono da considerarsi un fattore positivo “se” inseriti in un contesto sistemico di una economia sana, ovvero per tempi non eccessivamente lunghi in un contesto di difficoltà economica, mentre costituiscono un problema se “troppo bassi per troppo a lungo” (cd. “sindrome giapponese”, anche se lì incide molto una diversa dinamica anagrafica), soprattutto in un contesto economico di crisi.
Ma, ancora, cosa succede se riprendessero a salire? Soprattutto in maniera non controllata? L’obiettivo dell’allargamento del QE della BCE è (appunto per evitare le secche dei rischi prima descritti) quello di riportare il tasso di inflazione intorno al target del 2%. La “dirimpettaia” FED americana è da qualche trimestre che sta rinviando la decisione (attesa peraltro dai più entro fine anno/primavera prossima) di rialzare i tassi. La BoE (Bank of England) probabilmente sarà costretta a rivedere le decisioni sui tassi per effetto dell’aumento di inflazione “importata” a seguito della svalutazione della sterlina post-brexit (con buona pace della “neutralità finanziaria” delle “svalutazioni” monetarie). Già solo questi elementi basterebbero per poter intuire come sia probabile uno scenario prossimo venturo di rialzo. Tema che rischierebbe però di divenire meno “controllato”, nei suoi effetti, in caso di progressiva disgregazione della moneta unica.
Gli effetti di un rialzo inflattivo sarebbero certo positivi, se limitato a una soglia “bassa”, mentre diverrebbero negativi (una sorta di “tassa” sui redditi “fissi” e, più in generale, sui ceti meno abbienti) se fosse a “percentuali elevate e per tempi lunghi”. Oggi però la seconda ipotesi appare (ai più) poco diversa da un semplice “spauracchio”, tanto da alimentare tesi alquanto “alternative” in spregio a tale rischio, mentre la prima non pare (nonostante le azioni messe in campo dalla BCE) riuscire ad affermarsi nei dati economici generali. Tecnicamente, ciò dipende dal fatto che l’effetto di “monetizzazione” del debito (è tale quando una banca centrale acquista in emissione titoli del debito pubblico: se per 100 sottoscrive, per 100 aumenta la massa monetaria; aumenta l’inflazione “e” il debito pubblico, quindi il “livello” di “monetizzazione” andrebbe sempre tenuto sotto controllo, per evitare eccessi) è nel QE europeo solo parziale (cioè i titoli sono acquistati sul mercato secondario dalle banche, che non necessariamente reimmettono in circolo – con investimenti o nuovi crediti – i capitali ottenuti; e questo non per cupidigia, ma spesso per problemi di bilancio dati dalle perdite su crediti ed avversione al rischio verso un’economia debole e tuttora in crisi).
Insomma, dopo tutto quanto esposto, sembra più un gatto che gira in circolo e si morde la coda, piuttosto che un percorso lineare che ci porti fuori dalle secche della crisi. E quindi, come è possibile muoversi per non commettere errori? E che sorte avrà l’investimento nel titolo cinquantennale a tasso fisso da cui siamo partiti?
Intanto, occorre ricordare che gli effetti dei movimenti sui tassi di interesse sono diversi al variare della posizione soggettiva (creditore o debitore), del “sottostante” analizzato (titolo o debito che sia, se a tasso fisso od a tasso variabile), delle eventuali “limitazioni” di rischio (presenza di “stop loss” o “stop profit”; utilizzo di “derivati” di copertura, siano essi “plain vanilla” o più “strutturati”; si operi “allo scoperto” o meno; si sia in mercati liquidi o illiquidi). In prima approssimazione, per quanto qui sintetizzabile, le variazioni dei tassi incidono sui prezzi dei titoli (se i tassi aumentano, aumentano i corsi degli strumenti a tasso variabile e diminuiscono quelli relativi a strumenti a tasso fisso); non modificano il valore nominale a scadenza (occorre però tener conto dell’effetto di “attualizzazione”, tanto più rilevante quanto maggiore è la durata del titolo); determinano una variazione nella valutazione di convenienza o meno dell’utilizzo di “derivati” di copertura (in funzione degli scenari successivi prevedibili). Sul lato imprese, per quelle “prenditrici di debito”, oltre al costo del denaro, si modificheranno la leva finanziaria operativa (confronto fra “roi” e “i”) ed il costo medio ponderato del capitale (cd. “wacc”, per il triplice effetto della variazione del tasso di interesse medio “i”, del conseguente calcolo dello “scudo fiscale” dato dalla deducibilità del debito e della misura del “rischio” stesso inserito nel calcolo), generando così impatti sulla valutazione degli investimenti, dei business plan e del valore economico stesso delle aziende.
Che sia dunque per investimenti, per finanziamenti o per l’equilibrio delle finanze pubbliche, il tema dei tassi (qui riassunto con semplice intento divulgativo e, pur nel rigore della trattazione, senza pretesa scientifica, che richiederebbe invece ben altro grado di approfondimento), resta uno dei temi più rilevanti – quello “centrale”, ad avviso di chi scrive – e del tutto ineludibile, invero, a cui dedicare attenzione nel consigliare e nell’attuare scelte (razionali) di natura finanziaria, oltre che per valutare consapevolmente gli scenari futuri.
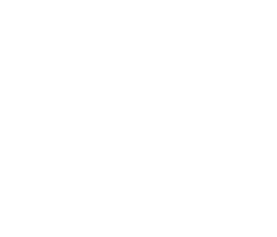
eventi
Triveneto: Riccardo Borgato alla guida della Conferenza che riunisce i presidenti dei 13 OrdiniIl neo eletto (presidente Odcec Rovigo) coordinerà l'Associazione con i delegati regionali Mario Giamporcaro (presidente Odcec Trieste) per il Friuli Venezia Giulia e Raffaella Ferrai (presidente Odcec Trento) per il Trentino Alto Adige
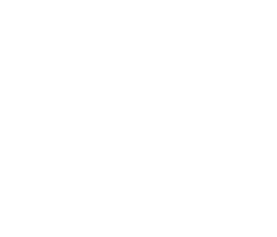
fisco
Riforma fiscale, appuntamento a Bari il 17 maggio con Fitto, Leo e de NuccioConvegno organizzato da Consiglio nazionale dei commercialisti e Università LUM. Tre tavole rotonde sugli aspetti fiscali, contabili e di sostenibilità della cooperative compliance
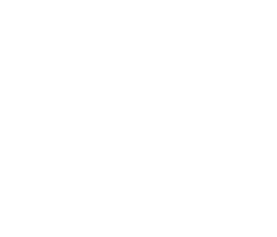
fisco
Complessità del sistema normativo, il 16 maggio convegno alla LuissIl presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, parteciperà alla tavola rotonda "Il ruolo dei professionisti: la mediazione fra cittadini e testi incomprensibili"